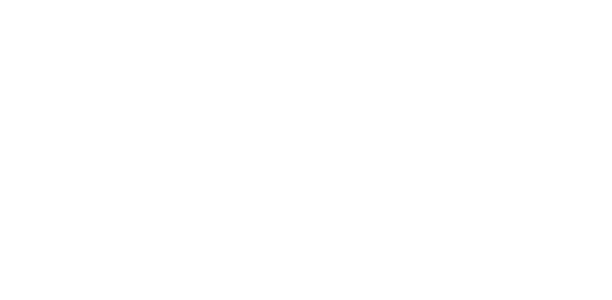Per il secondo anno consecutivo, oggi ho varcato la soglia del Castello di Hartheim, un luogo che trasuda dolore e orrore. Qui, per i nazisti, le persone con disabilità fisica e intellettiva non erano esseri umani, ma un fardello da eliminare. Considerate inutili perché incapaci di lavorare, furono destinate a una fine crudele e pianificata con fredda efficienza.
L’Aktion T4 fu il programma di «eutanasia» ideato per questo scopo: uno sterminio sistematico e silenzioso. Hartheim fu uno dei sei luoghi deputati a questa atrocità. Tra maggio 1940 e settembre 1941, in soli sedici mesi, oltre 18.000 persone furono assassinate qui, soffocate dal monossido di carbonio nella camera a gas, nascosta dietro le mura di una stanza al piano terra.
L’orrore non si fermava alla morte. I familiari venivano ingannati, convinti che i loro cari fossero trasferiti in strutture adeguate per ricevere cure. La realtà, invece, era ben altra: il viaggio dal pulmino alle camere a gas e poi al forno crematorio si consumava in poche, gelide ore. Un’operazione resa possibile grazie alla complicità di medici e personale sanitario che avrebbero dovuto proteggere la vita.
Ascoltare oggi i racconti di chi conosce questa storia da vicino ha lasciato tutte e tutti noi senza parole, con un brivido che correva lungo la schiena.
Qui mi sono commossa, ci siamo commosse e commossi, ascoltando le parole di una insegnante di sostegno e di due ragazze che hanno chiesto la parola per esprimere il proprio sdegno.
È stato significativo ascoltare di nuovo qui, dopo averlo fatto di fronte ai resti della baracca 29 di Dachau, la musica dei ragazzi del Conservatorio di Musica Pietro Mascagni di Livorno, un omaggio per chi da questo Castello non è mai più tornato.
Questo castello è la prova tangibile e straziante di dove possa condurre una visione del mondo che considera le differenze come un peso da eliminare.
Hartheim ci lascia un monito potente: la dignità e il valore di ogni persona non devono essere mai negoziabili.